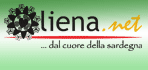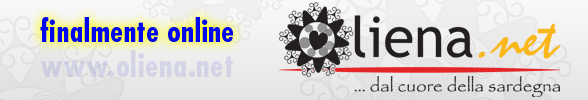Architettura e chiese

Architettura
L'insediamento urbano
Ubicato alle falde della montagna (Corrasi e Carabidda) la cui parete rocciosa si cala a picco costituendo una quinta naturale sul lato Sud-Est, il centro abitato di Oliena si adagia su un territorio notevolmente accidentato, con forte pendenza (circa il 20%) verso Ovest. La configurazione che ne consegue assume la caratteristica espressione a gradoni. Il tessuto urbano appare suddiviso dal rio Golathi, semplicemente «su rivu» (il rio), in due rioni principali: «Sa Banda manna», il più grosso, sulla sinistra guardando il Supramonte, e «Sa Banditta» sulla destra; in essi possono individuarsi numerosi altri rioni secondari.
La toponomastica storica, ancora oggi di uso corrente fra gli olianesi, consente di individuare un centinaio di piccoli rioni che fanno capo prevalentemente alle numerose chiese (attualmente ne rimangono undici) distribuite con equilibrio su tutto il centro abitato.
Lungo la periferia Nord scorre un altro piccolo corso d'acqua, «Su riveddu», che stacca il quartiere di San Francesco e Santa Anna, senza soluzione di continuità; infatti questo quartiere fa corpo con quello di «Sa Banda manna» e il corso d'acqua è visibile solo negli orti che vi si attestano come cortili degli edifici che sorgono nelle immediate vicinanze.
Nel settore di destra, «Sa Banditta», è riconoscibile il vecchio e povero rione «Sa Teria», costituitosi fra il Seicento ed il Settecento con la confluenza di una parte degli abitanti del distrutto villaggio di Locoe che, si dice, vennero cacciati da Orgosolo.
La maglia viaria appare molto irregolare, ma in essa è facilmente riconoscibile la rete principale, costituita in sostanza da tre assi ortogonali che si aprono, oltre la quinta naturale di S-E, verso Nuoro, Dorgali e Orgosolo.
Sull'asse trasversale, Orgosolo-Dorgali, confluisce una fitta rete di strade strette e ripide che, seguendo le linee di massima pendenza, distribuiscono alle diverse unità abitative.
I lotti residenziali, evidenziati dalla rete viaria, hanno forma complessa, irregolare e costituiscono piuttosto un agglomerato accorpato di unità semplici servite prevalentemente da un cortile interno. Ad esso si accede dalla viabilità principale con diramazioni che seguono le curve di livello, attraverso passaggi carrabili voltati o architravati.
Le architetture spontanee, semplicemente determinate da concetti di base ben radicati nella cultura locale e strettamente connessi con il singolare modo di vivere, riservato e allo stesso tempo comunitario, costituiscono la caratteristica principale del tessuto urbano di Oliena.
Testo di Michele Pintus
La crescita urbana
Nel corso degli ultimi due secoli e comunque sino alla metà del Novecento, la struttura urbana di Oliena si è conservata senza sostanziali modifiche, come si può rilevare dal raffronto della cartografia storica: catasto De Candia (1846), vecchio catasto (1900), nuovo catasto (1932).
Il fenomeno progressivo di saturazione edilizia del centro abitato ha mantenuto inalterati i tracciati viari che delimitavano sazi originari ad uso misto: abitativo, agricolo e pastorale. È ne successivo cinquantennio (cartografia I.G.M., 1962, EIRA, 1970, attuale) che l'edilizia residenziale ha avuto un notevole sviluppo, operando secondo canoni architettonici quasi sempre completamente differenti da quelli esistenti nel suo centro storico.
La crescita ha seguito direttrici preferenziali imposte dalle condizioni geo-altimetriche del territorio. Il vincolo imposto dalla barriera calcarea del Supramonte e dal compluvio dei corsi d'acqua che attraversano il paese (rio Golathi e su Riveddu) ha guidato l'espansione secondo tracciati viari principali. La forma accorpata del centro originario si è quindi aperta a stella con tre punte orientate secondo i poli di interesse determinati dai centri più vicini, Nuoro, Dorgali e Orgosolo, con maggiore o minore intensità abitativa in relazione all'influenza esercitata dal polo. Tale espansione, individuata nelle tre direttrici principali, è in realtà priva di una polarità propria; per i servizi e i centri di aggregazione è del tutto dipendente dal vecchio centro. Esso permane come sede di poli principali d'uso collettivo, come la chiesa parrocchiale ed il comune, e come centro vitale, punto di raccordo e di incontro per l'intera popolazione.
La parte nuova del paese, che ricorda i modelli della periferia urbana, gravita ancora e vive parassitariamente accanto al vecchio centro pur assicurando vantaggi qualitativi e funzionali dal punto di vista abitativo. La moderna concezione degli spazi interni destinati alla residenza con ambienti disimpegnati e sufficientemente serviti, esercita una forte attrazione, con la conseguente tendenza ad abbandonare la vecchia casa e ricercare nuovi spazi da edificare.
Testo di Michele Pintus
Le strutture abitative
La maglia viaria, irregolare nella sua configurazione planimetrica, è determinata da un tracciato ordinato che riflette l'andamento altimetrico del terreno. Essa presenta una viabilità principale ortogonale alle curve di livello, quindi secondo le linee di massima pendenza, e diramazioni secondarie a servizio di isolati abitativi che si racchiudono molto spesso intorno a uno spazio interno. Una sorta di “patio” quindi, più o meno esteso, caratterizzato dalla presenza di scale esterne variamente articolate, che permettono il collegamento con i diversi locali a quote differenti e appartenenti a diversi proprietari.
Accogliente e suggestivo, lo spazio interno costituisce molto spesso il prolungamento della strada da cui si dirama; la numerazione civica infatti continua sulle porte che vi si affacciano, non limitandosi al solo passo carraio, che è sovente l'unico accesso dalla via pubblica. Uno spazio di vita interna, riservato e comune, nel quale, nelle versioni più antiche e meglio conservate, vi è ancora il pozzo da cui tutti possono attingere l'acqua e l'accesso ai piccoli cortili che sono conseguenza del frazionamento di un lotto più ampio riservato a orto. In esso ogni famiglia conserva la legna per il camino, sempre presente anche nella più piccola e modesta unità abitativa, e, nei tempi passati, teneva le galline, il maiale e gli animali da lavoro.
La parte del lotto che si affaccia su strada può avere accesso diretto e talvolta, data la pendenza forte, il livello di ingresso viene assicurato con una scala esterna che ingombra la strada e si sviluppa, anche con pochi gradini, parallelamente ad essa. Su questo esempio sono frequenti le soluzioni di più ingressi con un unico accesso dalla strada; la tipologia più diffusa presenta una rampa con pochi gradini, che non ingombra più la strada, ma è ricavata in un apposito vano aperto ad arco, voltato o a copertura piena, fino ad un pianerottolo comune dal quale si dipartono le scale a servizio delle diverse dimore, solitamente a livelli differenti.
Altre volte l'ingresso ai vani d'abitazione è volutamente portato al piano superiore, sempre con scale esterne, e il piano terra è utilizzato come magazzino, deposito o, nel passato, ricovero notturno per gli animali da cortile e l'asino.
La ricognizione condotta su tutto il centro abitato dal gruppo di lavoro e la restituzione di rilievi accurati hanno evidenziato l'assenza di tipi ripetuti, derivabili da unità base comuni. Si riscontrano piuttosto caratteristiche costanti negli elementi costitutivi di base: la varietà di elaborazione e di articolazione, anche in relazione al suolo, determinano soluzioni sempre modificate, ricche di complicazioni interessanti che annullano la monotonia della ripetitività. Dalla casa più povera, monocellulare con accrescimenti in altezza, in larghezza o profondità, si passa gradatamente alla casa padronale molto più ampia, tanto da occupare talvolta un intero isolato (casa Canudu), con la stessa spontaneità architettonica.
Testo di Luciano Ramon
I materiali e i particolari costruttivi
La natura del suolo, prevalentemente granitica, offre un ottimo materiale da costruzione; molto usato è anche il calcare e, in misura più limitata, lo scisto. Gli edifici nascono sovente sulla roccia viva; su di essa è ricavato il piano di calpestio a quota sopraelevata rispetto alla strada e il basamento naturale di fondazione è lasciato in vista sul prospetto.
Le pietre sono messe in opera promiscuamente, ad opera incerta, ma talvolta con un ordine cromatico o dimensionale preordinato. I pezzi speciali, come gli stipiti, gli architravi, le soglie, i davanzali sono scelti tra pietre di eguale colorazione e realizzati in elementi monolitici rozzamente sbozzati.
Molto diffuso è l'uso di un timpano di scarico realizzato con due blocchi lapidei, in genere granito, disposti a triangolo sopra l'architrave delle aperture, che in questi casi è poco resistente. Il ginepro è un'essenza lignea largamente usata come materiale da costruzione, sia per risolvere problemi di resistenza che di finitura, sostituendo molto spesso gli architravi monolitici in pietra o quelli alleggeriti con il timpano di scarico o addirittura l'intera struttura portante del portale di accesso al cortile comune. I passi carrabili sono solitamente voltati a botte, realizzata in pietra o in mattoni crudi, ma molto spesso sono architravi con travi portanti di ginepro e voltine o completamente in ginepro con travi affiancati in successione orizzontale e sovrastante livellamento in muratura.
Le scale sono realizzate con gradini in blocchi di granito su volta in mattoni crudi o, quando manca il blocco monolitico, l'alzata è realizzata sempre con trave di ginepro lasciato in vista e successivo riempimento con materiale lapideo in lastre o mattoni crudi. Tutto appare realizzato in grande economia e, nei casi normali, il contadino o il pastore, capaci di realizzare in campagna «su pinnettu» (la capanna) e i recinti per gli animali, «sa mandra», erano anche in grado di costruirsi un alloggio stabile nel centro abitato. La copertura ricopre gli ambienti senza interposizione di solaio; si può vedere un massiccio trave centrale, «su petzu», sul quale poggia la duplice fila trasversale di travicelle, «sos currentes», sempre di ginepro, e il graticcio di canne, «sa cannitza», sul quale sono adagiate le tegole. I travicelli della copertura sporgono dal filo della muratura determinando il tipo di gronda a dentelli; talvolta aggettano fino a coprire il balcone in legno (oggi ormai quasi totalmente scomparso) sporgente dalla facciata. Ai lati delle finestre ai piani superiori è ancora possibile vedere delle lastre in pietra ancorate alla muratura e utilizzate probabilmente come portavasi; altre volte davanti al davanzale sporgono dei tronchi di ginepro sui quali presumibilmente si sistemava l'assito in legno, ottenendo
una sorta di ripiano.
Testo di Luciano Ramon